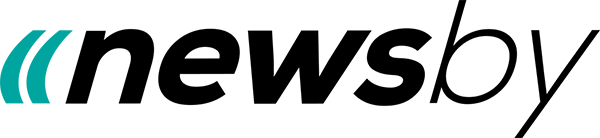C’è una sottile linea rossa fra la capacità di fare informazione e consegnare ai propri lettori notizie nella maniera, nel linguaggio, nel contenuto che questi gradirebbero. Fra la narrazione della realtà, trasparente, cruda, vera, e la tentazione di accontentare i clienti.
Già, perchè questo è oramai il pubblico dell’industria editoriale. Poco importa se ad esserlo sono i lettori dei giornali cartacei, gli utenti di quelli online, se è il comparto pubblicitario che investe ma che deve essere soddisfatto e appagato da quanto proposto, o addirittura l’editore stesso, che nella maggior parte dei casi ha ben altri interessi economici che animano la sua guida a capo della testata o del gruppo di turno (ogni riferimento a fatti di recente avvenuti è puramente voluto).
Il caso dell’editoria italiana: l’involuzione della specie
E’ l'”involuzione della specie”, in questo caso dell’editoria, che da quasi vent’anni prova a rinnovarsi con tonfi colossali.
L’avvento di Internet, lo abbiamo detto in tutte le salse, ha sparigliato le carte: in un’industria totalmente impreparata a gestirne l’arrivo, l’immediatezza, la tecnologia, a farne le spese è stata da subito la qualità di quella stessa informazione che per decenni era stata la stella polare in gran parte dei quotidiani, dei magazine, delle riviste che sfogliavamo con quella curiosità che, da lettori, chiudeva il cerchio inaugurato dall’intuito del giornalista.
Non è stato più così. La “chiamata” della digitalizzazione non è mai stata vista, davvero, come un’opportunità dai decisori, se non per un solo ed esclusivo motivo: tagliare i costi a beneficio dei guadagni a breve termine.
Sia chiaro che chi scrive è concettualmente lontano dall’interpretare una qualche ipocrita ortodossia professionale: la mia presenza su questo sito, nato da pochi giorni, sta anzi a testimoniare le colpe che attribuisco ai protagonisti dell’universo editoriale, compresi i colleghi giornalisti; guai, poi, a puntare il dito a prescindere contro chi ha capito che i paradigmi – anche economici – dell’informazione potessero cambiare a proprio piacimento. E’ il business, baby.
Fa più sorridere, con la dovuta amarezza, che il giro delle solite poltrone sia però rimasto ben intatto durante un valzer che ancora non si è compiuto, caratterizzante il comparto editoriale italiano. E’ come se si fosse creata una stratificazione ben marcata fra chi comanda, tutto budget e distintivo, e chi cura la parte editoriale, sempre più accerchiato e delegittimato, vero, ma allo stesso tempo presuntuoso e vittimista nel restare nel suo orticello fatto di pass stampa simili a medaglie arrugginite e riottoso nell’imbattersi in conoscenze nuove di un mestiere che si evolveva.
Leggevo stamani questa intervista a Mark Thompson, Ceo del New York Times, planato a Manhattan nel 2012 dopo il suo mandato alla BBC e accolto con un tale scetticismo che nemmeno Allegri alla Juve o Crimi alla guida dei Cinquestelle potrebbero aver assaggiato.
Thompson aveva raccolto in eredità una testata indebitata e vecchia, con lettori in costante calo e una digitalizzazione, appunto, accennata senza troppa convinzione.
Otto anni dopo il New York Times guida la risicata lista delle testate internazionali moderne, sane e redditizie con 800 milioni di revenues dal digitale e 6 milioni di abbonati.
Un caso? No di certo.
Thompson e il New York Times: una rivoluzione trascinata dai millennials
Cito dall’intervista rilasciata ai colleghi di Open: “La mia azienda è composta al 50% dai millennial. Oggi in molti dipartimenti del giornale abbiamo leader ventenni che prendono decisioni. C’è stata una rivoluzione all’interno dell’organizzazione: i millennial si occupano di tutto – politica, esteri, cultura – e questo ci ha permesso di arrivare a loro (…)”.
Qualche malpensante – e sono sicuro vi sia anche fra i miei più cari colleghi – penserà che la rivoluzione ‘anagrafica’ di cui parla Thompson parta dall’intenzione di ridurre i costi del lavoro redazionale, affidandosi a giovani alle prime esperienze anzichè a firme dall’indubbio prestigio.
Qualora non bastassero i risultati citati, è lo stesso Thompson a rispondere a questa comoda interpretazione: “Sono davvero pochissime le persone del “vecchio mondo” che possono reggere la trasformazione di cui ha bisogno oggi un’azienda giornalistica. Persone che hanno fatto carriera in un modo pre-digitale come possono guidare la transizione verso il nuovo? Il carico professionale, tecnologico, ma anche personale ed emotivo che comporta questo lavoro è impressionante. Io riesco a sostenerlo ma siamo pochissimi. Una volta quelli che si occupavano di dati nei giornali erano gli uomini grigi in fondo al corridoio, oggi sono al centro del giornale”.
A ben guardare le redazioni di moltissimi gruppi editoriali italiani, dire che al NYT abbiano fatto centro appare un’ovvietà.
Ma restiamo nel tema della qualità giornalistica, cui tutti noi teniamo dall’alto del nostro malcelato purismo perbenista (che, sia chiaro, ogni tanto ben venga!). E’ forse calata data questa ventata di gioventù e innovazione?
La lezione che il NYT ci ha dato con il Coronavirus
A giudicare da come il quotidiano americano ha affrontato l’emergenza Covid-19, non si direbbe.
Nella giornata di oggi, della prima pagina del NYT (ma vi invito anche a consultare la versione online) stanno trattando tutti i media internazionali: un elenco di mille nomi, con una piccola e toccante descrizione a corredo di ognuno, in rappresentanza delle circa 100.000 vittime del Coronavirus negli Stati Uniti.
Una scelta forte, di strappo con i paradigmi abituali, sicuramente più istituzionali, che una testata tradizionale dovrebbe (secondo chi?) perorare; un attacco senza giri di parole, diretto, all’amministrazione Trump cui il quotidiano della Grande Mela imputa una reazione tardiva e superficiale alla luce di quanto già era accaduto in Cina, in Italia e in Spagna nelle settimane precedenti.
Anche se in profondità, un elenco che riscopre un valore morale del giornalismo cui non si è più abituati, occupati come siamo nella ricerca costante dell’articolo fomentatore dei nostri tifosismi o foriero di stereotipi e luoghi comuni da rivenderci sui social. Impegnati costantemente a convincere gli utenti a cliccare, piuttosto che badare alla cura di quanto si propone. Spettatori automi innanzi alla spettacolarizzazione non più solamente della notizia, ma anche di chi sarebbe chiamato semplicemente a riportarla, con i giornalisti che divengono superstar, conduttori di talk show politici che fingono imparzialità e poi redigono il giorno dopo editoriali di basso livello, nemmeno culturale, ma anche solo linguistico.
Quella del New York Times, poi, non è di certo la prima lezione che ci viene impartita dalla testata americana.
Il racconto per immagini (e necrologi) che dagli States fecero del dramma vissuto a Bergamo fu un esempio di vero giornalismo realizzato proprio in casa nostra. Quando, seguendo la scia sempre ispirata della politica, anche il sistema mediatico seguiva l’odore del sangue del colpevole da affossare anzichè il suono macabro degli ultimi respiri di tanta, troppa gente.
Non è stato tutto sbagliato ciò che si è visto in Italia, ci mancherebbe: ci sono colleghi e reporter che hanno narrato in maniera ineccepibile e con grande cifra qualitativa quanto stava accadendo e ancora oggi si verifica; così come non è tutto oro quel che luccica dagli open space di Manhattan.
Ma ritengo sia comunque l’ennesima, preziosa, occasione per riflettere su come un player internazionale si sia rialzato dalle ceneri e ora si muova brillantemente su due differenti tipi di mercato: quello del business puro, fatto di previsioni e visioni, di budget, tagli e investimenti; e quello delle news, della loro proposizione, del rapporto con chi dà a quei contenuti una fetta del loro tempo prima e della propria cultura poi, senza equipararlo a un semplice click.
Il tutto, senza rinunciare agli abbonati, alle views, alle firme divenute superstar, alle picconate verso la politica che delude o alle narrazioni di impatto emotivo e di valore morale.
Nel 2012 il New York Times ha messo un punto sul suo percorso, iniziandone un altro.
La prima pagina di oggi è solo una logica conseguenza di un cammino intrapreso otto anni fa cui l’editoria italiana dovrebbe iniziare a ispirarsi.