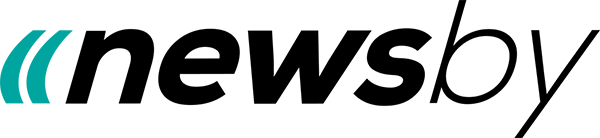Siamo abituati a vedere una profonda distinzione tra il mondo profit e il mondo no profit. Conviviamo spesso con le definizioni da manuale perché ci danno la sensazione di comprendere la realtà, che però a volte non segue i nostri schemi.
Il no profit nasce agli inizi del 900 dall’esigenza di prendersi cura di aspetti sociali non redditizi, ma di comprovata utilità collettiva. Fino a quel momento, il modello di business prevalente era quello venditore-acquirente e utilizzando quel modello era assurdo pensare di trarre profitto da un problema sociale. Sono nate, così, associazioni ed enti che beneficiano di un sistema fiscale agevolato per mitigare le problematiche che il business tradizionale non prendeva in considerazione.
Ma siamo davvero sicuri che questa divisione sia necessaria?
Il no-profit e un nuovo modello di business
Una delle innovazioni economiche moderne sta proprio nel modello di business: siamo passati dal semplice modello venditore-acquirente a modelli più complessi dove chi usufruisce del servizio, il beneficiario, non è colui che paga.
L’esempio classico è Google: nessuno di noi paga per fare ricerche, le aziende clienti pagano Google per la pubblicità, per le ricerche di mercato e tanti altri servizi. In poche parole, offrendo un servizio gratuito Google ha creato un valore per altre aziende.
Fino a poco tempo fa il successo di un’azienda veniva valutato in base al suo bilancio, al volume di affari e altri parametri economici; questi parametri creano un enorme differenza tra il mondo del profit e del no profit.
Immaginiamo che Google sia il miglior motore di ricerca sia per gli utenti che per gli inserzionisti, con questi ultimi soddisfatti dei loro investimenti pubblicitari. Possiamo affermare che la bravura nel realizzare un servizio eccellente sia la causa del successo di Google? Certamente sì: migliore sarà il servizio maggiori saranno le vendite; maggiori vendite, poi, portano più capitale da investire per migliorare ulteriormente il servizio o crearne di nuovi. Si crea un circolo virtuoso che accelererà notevolmente la crescita dell’azienda rendendola leader del mercato.
Pensiamo invece ad un’associazione che si occupa della distribuzione dei pasti per i poveri. Immaginiamo che l’associazione in questione sia la migliore nel trasformare le donazioni in pasti e che sappia distribuirli con efficienza. Possiamo affermare che questa associazione sia la migliore impegnata nella lotta alla povertà? Purtroppo, la bravura nell’erogare un servizio non basta se non è supportata da una raccolta fondi importante. La differenza sostanziale tra i due modelli sta proprio nella catena del valore: mentre per le aziende profit il servizio o il prodotto ne decretano il successo, nel mondo no profit servizi e risultati dipendono dall’attività di raccolta fondi.
Troviamo così realtà molto efficienti, piccole onlus gestite da poche persone che svolgono un lavoro eccellente, ma che non riescono ad avere un grande impatto proprio perché non raccolgono fondi sufficienti. Abbiamo poi le fondazioni che sono molto efficienti nella raccolta di capitali, ma molto meno efficienti nell’erogare servizi.
Il concetto di donazione, inoltre, non è ben visto nel mondo del business perché crea realtà “drogate” dipendenti da fattori esterni fuori dal controllo dell’azienda, senza contare che le persone sono molto più propense a fare un investimento accettando alcuni rischi piuttosto che fare una donazione.
Siamo ancora sicuri che profit e no profit debbano restare separati?
Quando le dinamiche sociali assumono valore economico
La separazione dei due mondi nasce dalla incapacità di vedere valore nelle problematiche sociali, anche se negli ultimi tempi gli orizzonti paiono allargarsi. Partendo dall’ambiente, è ormai chiaro come, nel preservare la biodiversità, la riduzione delle emissioni di CO2 abbia un impatto positivo sul nostro pianeta e di conseguenza anche un valore economico.
Se dovessimo aggiungere l’impatto ambientale nei bilanci delle aziende l’esito sarebbe devastante, specie per le aziende dell’industria pesante.
Alcuni strumenti come la carbon tax vanno in questa direzione, ossia cercano di dare un valore economico a quello che è un valore sociale; sebbene non sia facile dare un valore economico ad un mondo pulito è importante provarci per poter ragionare in termini economici.
Dal 2000, molti economisti hanno iniziato a lavorare sulla cosiddetta impact finance, cercando strumenti che rendessero più chiare le implicazioni economiche dei problemi sociali.
Il primo caso si è registrato in Inghilterra con i social bond, che altro non sono che una “scommessa” riguardo la soluzione di alcuni problemi sociali.
Prendiamo il problema della recidiva nelle carceri: un detenuto costa allo Stato italiano 137 euro al giorno; se decidessimo di pagare 50 euro al giorno ai detenuti per comportarsi bene rilasciandoli in libertà lo stato risparmierebbe sulla carta 87 euro al giorno, che per i 60.000 detenuti arriverebbe ad oltre 5 milioni al giorno. Ovviamente questo è un calcolo ipotetico, in questo modo mancherebbe totalmente l’aspetto deterrente del carcere oltre che la riabilitazione, ma un imprenditore sicuramente vedrebbe una grande opportunità di business.
Se riuscissimo a ridurre il numero di carcerati con metodi più realistici, ad esempio formando i detenuti per renderli pronti ad un lavoro al termine della detenzione, evitando i casi di recidiva, lo Stato avrebbe comunque un risparmio e potrebbe utilizzare parte di questo risparmio per investirlo o ricompensare gli investimenti fatti nel settore.
Questa è in modo semplice la definizione del social bond secondo lo schema anglosassone. Per poter funzionare necessita di un ente garante, che si impegna a premiare economicamente coloro che riescono a ridurre le spese sociali.
I social bond sono uno strumento che probabilmente cambierà il terzo settore, ma avendo una complessità elevata bisognerà aspettare ancora un poco.
C’è un altro scenario, a mio avviso più interessante e dinamico: il meccanismo capitalistico impiegato nei problemi sociali. L’imprenditoria sociale non necessita di garanti: tutto si basa sul capitale e sul rischio, in questo caso con l’aggiunta di una missione sociale, nascono così le imprese dell’assurdo come la Grameen Bank, definita la banca dei poveri, fondata nel 1976 dal premio Nobel Muhammad Yunus.
Il concetto che sta alla base della Grameen Bank è esattamente l’opposto di quello su cui si sono basate le banche tradizionali: l’affidabilità creditizia. È risaputo che le banche non prestano soldi a chi non ha referenze, ma in un Paese povero come il Bangladesh i poveri si sono rivelati degli ottimi pagatori, anche meglio dei ricchi. Sono queste intuizioni che, se messe in pratica, permettono la nascita di imprese impossibili come una torrefazione gestita da senzatetto, una compagnia telefonica per le persone sorde e così via.
Di fronte e queste realtà la distinzione tra profit e no profit viene meno, lasciando spazio all’immaginazione e alla creatività degli imprenditori, i quali possono mettere le loro capacità al servizio della società dimostrando che applicare le logiche imprenditoriali ai problemi sociali non solo è possibile, ma soprattutto sostenibile e replicabile.